La poesia Ignazio
Pubblicato in “Un fiore all’occhiello”, febbraio 2019Questo d’Ignazio è il sesto libro di poesia. Da quando si è ritirato, già avanti negli anni, dall’attività di avvocato, Ignazio ha vissuto ogni suo giorno pensando alla poesia. L’ha fatto quando nella sua casa c’era la moglie Itala, compagna di una vita; l’ha fatto dopo, quando è rimasto solo. Poesia come necessità, aria del giorno; poesia come ragione di vita per comprendere il proprio tempo: sono questi i puntelli del suo impegno quotidiano per la poesia.
In questi anni Ignazio ha scritto molto. Per lui è naturale avere vicino a sé, nell’ora dell’allodola o in quella della civetta, un foglio bianco e una buona penna e, con la sua grafia vibrata, per l’età e per l’emozione di quel fare sempre speciale che è scrivere versi, tentare la poesia. All’inizio sono solo abbozzi di strofe che lui diligentemente ripone in un’apposita cartellina. A volte gli capita di riprenderli subito, a volte dopo giorni, talvolta anche dopo settimane o mesi. Li ritocca, li riscrive fino alla loro intima perfezione. Quando ogni parola è esatta al proprio posto, allora, li trascrive al computer, non sempre invero, e viene da me, che sono il suo editore, a leggerli e a commentarli assieme. Sono pochi minuti, ma sono intensi e unici… forse un giorno non ci saranno più i poeti come li abbiamo conosciuti noi, poeti come Ignazio, e sarà un rimpianto.
Dopo aver compiuto la lettura, la nuova poesia torna nella solita cartellina a giacere con le altre, a suo tempo lette. Quando le poesie arrivano a un certo numero, Ignazio le raccoglie in un libro.
Questo è il sesto e ha una piccola grande sorpresa, che mi aspettavo da tempo. Perché i poeti come Ignazio, che vivono un rapporto giornaliero con la poesia, che ha sempre un suo prezzo di fatica e sempre meno una sua domanda di pubblico, a un certo punto si chiedono le ragioni del loro fare. Perché scrivere, che è fatica, quando nessuno chiede più la poesia?
Tutti gli autori di più libri hanno risposto a questa domanda. Zanzotto le ha chiamate “poetiche lampo”. Si tratta di vere e proprie rivelazioni sul perché e sul come si è scritto poesia. Spesso sono pochi versi, talvolta anche solo poche parole, sempre tuttavia nascoste nelle pagine meno attese della loro vasta opera. Parole speciali, “cellule esemplari e seminali” (Zanzotto), parole-chiavi che aprono d’incanto lo scrigno di tutta la loro poesia. Cos’è la Commedia? Perché l’ha scritta? Dante per primo se l’è chiesto. La risposta la troviamo nei primi nove versi del Venticinquesimo canto del Paradiso. Per farci capire che in quell’incipit Dante sta parlando proprio di sé e di nessun altro, mette al centro del 5° endecasillabo, che a sua volta è il centro (4+1+4) delle tre terzine, un potentissimo e rivelatorio “io”. Ecco allora l’annuncio: la Commedia è il “poema sacro/ al quale ha posto mano cielo e terra”; ed ecco perché l’ha scritta, a costo di un’immensa fatica, “…che m’ha fatto per molti anni macro”, poter tornare nella sua Firenze, riconosciuto e accolto in tutto il suo valore di cantore di cose alte e divine. Dante ha scritto l’opera più complessa della letteratura occidentale per guadagnarsi il più semplice dei riconoscimenti, il ritorno a casa.
Identica rivelazione la troviamo in Leopardi, a cui bastano tre versi dell’inno che fa da preludio al dialogo tra il dottor Ruysch e le mummie, contenuto nelle Operette Morali, per darci la chiave di tutta la sua poesia: “Che fummo?/ Che fu quel punto acerbo/ che di vita ebbe nome?” In queste quattro parole, punto-acerbo-vita-nome, c’è tutto Leopardi, il suo male di vivere, oggi diremmo la sua irrisolvibile depressione, che l’ha fatto poeta e c’è la natura della sua poesia, quella angosciata “dottrina interrogante” su un’esistenza umana in sé fatalmente incomprensibile.
Leggere l’opera di un poeta è trovare queste parole, questi microtesti illuminanti e rivelatori, nascosti nelle pagine meno probabili della sua opera, come nel caso di Ignazio, che in sei libri, circa mille poesie, egli ci offre la sua “poetica lampo” nella pagina più evidente e più sfuggente di ogni altra, che è quella dedicata all’exergo, in cui scrive “La verità/ luce/ fiaccola di vita/ nell’incerto cammino”.
Ecco la ragione della poesia d’Ignazio, i suoi “perché” e i suoi “come”. Ignazio è poeta per amore della verità che è “luce”, è “fiaccola” nel “cammino” “incerto” della “vita”. In queste poche, fulminanti parole è spiegato il suo impegno poetico. Ignazio è poeta per amore di quella “verità” che si ottiene attraverso la parola.
E’ un amore antico, questo, vissuto oggi nella poesia, ieri nell’esercizio dell’avvocatura, in un remoto passato nella parola dell’insegnante verso i suoi allievi. Tutta la vita di Ignazio si dipana nella ricerca della verità di parola. Era un giovanissimo laureato in legge quando arrivò a San Quirico di Valdagno a insegnare come maestro elementare. Si era laureato a Palermo nel 1946, dopo aver compiuto gli studi classici presso il liceo di Gela. Era arrivato a Valdagno, perché della valle gli aveva parlato suo padre che aveva combattuto sul Pasubio nella Prima guerra mondiale. Un maestro del profondo sud per allievi del profondo nord. La San Quirico del millenovecentocinquanta è un posto a sé, per metà Valdagno, per metà Recoaro, un po’ industria e un po’ natura, operaia e boscaiola allo stesso tempo. San Quirico è il transetto di quella navata che è la Valle dell’Agno di cui Recoaro è l’abside; San Quirico è l’orifizio della Conca di Smeraldo di cui la Valle dell’Agno è il budello alla pianura. Ignazio vi piombò “senza lingua” per insegnare a quei ragazzi, che, come gli allievi di Zanzotto, come tutti gli scolari del mondo e di sempre, sono giovani “ignoti a se stessi e agli altri, più che tabula rasa sono tabula aliena, … tabula fatta di un materiale assolutamente imprevedibile, impastati di ignoto futuro e di nulla”. Il punto d’incontro tra loro fu la lingua che s’inventarono. Il maestro “fuin”, tutto nervetti e vivacità, e i “carusi” pretelevisivi, che parlavano solo in dialetto: due mondi distanti anni luce che si sono incontrati nella parola di verità che vicendevolmente hanno saputo offrirsi.
Fu così, ancora parola-verità, quando cominciò a fare l’avvocato nella “Piccola Grande Pretura” di Valdagno, “espressione di giustizia immediata”, e poi nei gradi superiori, fino alla Cassazione, tra gli alti, nobilissimi principi costituzionali e un corpo di leggi in preda a lallazioni e borborigmi, sostanzialmente schizofrenico, in cui, ancora oggi come nelle “grida” del Manzoni, “nessuno è reo e nessuno è innocente”. Nel babelismo giuridico italico, Ignazio ha dedicato tutto se stesso ad “azzeccare” verità che rendessero giustizia ai suoi assistiti.
Ignazio ha creduto nella parola, nella sua intima norma; Ignazio ha creduto nella verità che attraverso la parola ci è permessa: è stato maestro, avvocato, ora è poeta sempre nel medesimo credo.
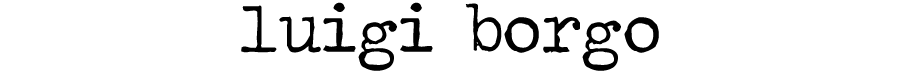




Leave a Reply