Ultimi e Penultimi dipinti di Franco Meneguzzo
Pubblicato in “Ultimi e Penultimi”, Mediafactory Edizioni, Settembre 2018Nel dicembre del 1973 Franco Meneguzzo, nel pieno della fase più complessa della sua carriera di artista, è chiamato a inaugurare la galleria civica di Valdagno, una piccola sala, una quarantina appena di metri quadrati, detta dei “Nani”, orgogliosa conquista municipale nella città dei “Premi Marzotto”. La mostra ai “Nani” costituisce un momento importante per l’artista e per la città. Sono molte le attese di chi avrebbe visto per la prima volta la sua più recente produzione vent’anni dopo il suo trasferimento a Milano; come sono tanti gli inevitabili mugugni degli artisti e degli intellettuali locali, poco più giovani, che per l’inaugurazione della nuova galleria civica al posto di Franco Meneguzzo avevano allegramente tentato d’imporre il “foresto” nome del “marzottiano” Santomaso, dopoché, dieci anni prima, senza alcuna memorabile protesta da parte loro, veniva demolita e fatta sparire da Valdagno l’opera in assoluto più grande di Santomaso, l’imponente facciata concava del teatro “Rivoli”, tutta rivestita in ceramica cangiante alla luce del sole nelle sfumature ora del turchese ora del verde: un frontale di 400 metri quadrati, una specie di mare verticale, di enorme cascata, omaggio a quell’acqua che ha segnato lo sviluppo e il benessere della valle prima con il termalismo e poi con la grande industria laniera. Da un lato, quindi, a meno di un lustro dal ’68, ai “Nani” si celebra con tutta la retorica possibile l’indipendenza della comunità civile dall’egemonia, anche artistica-culturale, della grande fabbrica; dall’altro si vive tutta la retorica del ritorno dell’eroico figlio della città, che viene a dar prova di sé tra i suoi concittadini, dopo aver sfidato con successo il mondo metropolitano dell’arte. Perché inaugurale, perché civica e non marzottiana, perché di un ex concittadino tornato in qualche modo vittorioso, la mostra ai “Nani” ha appassionanti dinamiche sottotraccia, eppure non è questo che la fa essere decisiva per la comprensione dell’opera di Meneguzzo. Quello che conta, e che va colto, è che in quel dicembre del millenovecentosettantatré, ai “Nani”, Franco Meneguzzo vive il momento più complesso e più difficile, perché terminale, della sua vita di artista. A Valdagno aveva iniziato a dipingere; a Valdagno sentiva che stava per concludersi la sua attività di pittore. Quei quadri “Verdi” appesi alle pareti sarebbero stati, di fatto, gli ultimi di quel viaggio straordinario nella pittura del ‘900 che fu il suo; la mostra ai “Nani”, il capolinea di un percorso dallo svolgimento lineare come pochi; “a note legate, direbbe un musicista”, logico, coerente, straordinariamente unitario. Sillogistico nelle correlazioni tra un momento di pittura e il suo successivo.
Aveva iniziato appena dopo la guerra, nel 1946, con alcune prove figurative, quasi solfeggi di apprendistato alla pittura astratta, che avvierà nel 1949 con il cosiddetto “Astrattismo geometrico” (1949-1954) nella lezione delle avanguardie europee degli anni Venti, Kandinsky, Mondrian, Klee, per arrivare da quelle figure regolari, chirurgiche, “supremi triangoletti per Klee”, a elaborare, nel 1955, il suo personalissimo Informale (1954-1960), a detta di molti la sua migliore produzione, che lo fa nominare, nelle buone Storie dell’Arte del XX secolo, in elenco con i grandi nomi dell’Informale italiano: Vedova, Tancredi, Scanavino… Santomaso… Dal 1960, terminato il periodo della pittura Informale, egli svilupperà quel ciclo di dipinti che Gillo Dorfles chiamerà “Sottrazione di colore” (1960-1964) che sono i “Penultimi” della sua ricerca artistica, dove gli “Ultimi” (1964-1973), invece, sono i quadri “Verdi”, simili per soluzione tecnica ai precedenti, ma, rispetto a quelli, che sono coloratissimi, tutti di un solo colore. Al fianco di questi quattro momenti della pittura di Franco Meneguzzo si registrano altrettanti periodi di un’intensa attività di ceramista (1949-1963) e di scultore: “i ferri” (anni ’50-‘60) “le terrecotte” (fine anni ’50) “i bronzi” (anni ‘70) e, infine, un felicissimo lustro di disegni in china (1965-1970).
Un viaggio nell’arte, dicevamo, coerente e lineare, intenso e febbrile, vissuto nel rigore kantiano o veneto di 8 ore di lavoro giornaliere – andava in studio alle 8 e 30 e vi rimaneva, senza pause, fino alle 16 e 30, sabati compresi – in forza di una rara energia vitale, ma, un viaggio, che è durato meno di trent’anni e che si è interrotto, così, bruscamente, nei mesi in cui ritornava “con altra voce omai, con altro vello” nella sua Valdagno a prender “cappello” d’artista.
Sull’opera di Franco Meneguzzo molti e tra i maggiori critici d’arte hanno scritto. Di essa, si può dire che si conosca tutto. Com’è accaduto ai grandi, i quattro momenti della sua pittura e i quattro momenti della sua scultura sono stati, da tempo, tracciati con parole definitive. Meno, però, o affatto addirittura, si è indagato sulle ragioni per cui a soli 49 anni Franco Meneguzzo matura il convincimento di non dipingere più. Di dire a se stesso “basta!” Lui che fino all’età di 84 anni, quando “l’istante ove ognuno (è) attore stupendo” pone termine alla sua vita, era stato vitale e artista come pochi. Quali sono le ragioni per cui smette precocemente di dipingere? Perché per ben 35 anni è un esplosivo artista in off?
Gran parte della critica, che ha scritto su di lui dopo il 1973, non affronta il caso perché sostanzialmente non se ne avvede, sebbene a ogni nuova mostra, in ogni nuovo catalogo l’ultima produzione sia sempre datata all’anno Settantatré. Vero è che Meneguzzo è abilissimo a nascondere il suo “silenzio” creativo. Dalle sue parole, dal suo atteggiamento non trapelano i noti tormenti dell’artista in crisi. Anzi, dal 1973 al 2008 continua a essere quel vulcano di pensieri e attività che è sempre stato. Più di 30 mostre personali, oltre 60 partecipazioni a esposizioni collettive – una media di circa un evento ogni tre mesi – segnano gli anni del suo cosiddetto “silenzio”, durante il quale non smette mai di proporre idee, progetti, ne inventava febbrilmente uno al giorno: dai portali in bronzo per il Duomo di Valdagno a nuove piazze cittadine, a collocazioni di grandi sculture in luoghi pubblici; dall’istituzione di una fondazione a suo nome a una donazione di suoi acquerelli degli anni ‘40 a nome della moglie Bruna. A Milano, dove è rimasto a vivere fino al 2006, ha continuato ad andare in studio con assoluta metodicità, a frequentare artisti, a seguire le vicende proprie e altrui dell’arte, e così è stato quando è tornato a Valdagno, dove chi lo ha frequentato fino ai giorni del suo ultimo ricovero, ricorda il piacere e il bisogno che aveva di parlare solo e soltanto e sempre di arte.
La restante parte della critica che invece sapeva, perché non poteva non sapere, data la prossimità all’artista, ha ritenuto il fatto una faccenda estranea all’arte e non l’ha mai approfondito. Solo dopo la sua morte c’è stato chi ha colto che i quadri di Meneguzzo più recenti portavano una data ormai antica, spiegando le ragioni di questa sua lunga inattività, addirittura maggiore degli anni produttivi, 35 contro 27, nell’immagine poetica di un pittore omerico che, di polis in polis, ha vissuto l’ultima fase della sua opera nell’oralità di essa.
Comunque sia, ciò che è avvenuto alla fine del ’73 non è stata la scelta obbligata di un artista inaridito. O di un artista in overdose di faccende d’arte. Meneguzzo non è né svuotato né in fuga dall’arte. Non è un caso Salinger il suo. Nemmeno un caso Celan. Non si è nascosto dal mondo, né si è “ammutolito”, quale effetto di una forza deteriore che lo ha sopraffatto. Egli è semplicemente “silente” sul piano del fare e questo gli permette di essere comunque, anzi, forse di essere ancor di più coinvolto dalle faccende artistiche sul piano dell’impegno espositivo, intellettuale, relazionale e, com’è ovvio, emotivo. Le testimonianze al riguardo sono infinite. Quell’anno, ai “Nani”, non si celebra nessuna uscita di scena. Meneguzzo continua a essere l’artista di sempre in pubblico, anche se non lo è più in studio. Nessun segno di disagio emerge da questa che potrebbe essere una dirompente contraddizione esistenziale. Sebbene sia difficile pensare che un pittore che non dipinge, non sia un pittore in crisi, Menuguzzo non lo è. Non lo è nel modo più assoluto. C’è una lettera datata 28 marzo 1988 di Gigi Meneghello a lui rivolta, in cui lo scrittore ammette, con l’avanzare degli anni, la sua sempre crescente difficoltà a scrivere tutto ciò che ancora ha in volere di raccontare. Dalla parte del destinatario della lettera, invece, si percepisce l’esatto contrario: la più totale serenità in merito alla sua opera, che evidentemente egli considera cosa fatta, cosa compiuta.
I tormenti che l’affliggono, piuttosto, sono altri. Le ragioni che animano le sue frequenti, focosissime ire sono l’esaltazione divistica da parte della critica e dei media di artisti, più furbi che geniali, alla cui opera non riconosce il minimo valore; le scelte politiche in materia d’arte, offensive della patria storia artistica, dove le piazze d’Italia sono parcheggi d’auto e le rotatorie viarie luoghi espositivi di affrettate installazioni di infimo grado; sono, se vogliamo dirla tutta, i riconoscimenti alla sua opera non considerati corrispondenti alla misura del suo valore. Era un uomo che non avrebbe rifiutato la fama, il divismo perfino e forse nemmeno la ricchezza, quale contrappasso calvinista di quanto lui aveva dato all’umanità con il proprio lavoro. Altro, che lo tormenti, non c’è.
La nostra ipotesi, allora, attorno alla quale è stata pensata la mostra di Castelgomberto, in cui si espongono i quadri “Ultimi” e “Penultimi” della sua produzione, ovvero i “Verdi” e quelli chiamati “Sottrazione di colore”, è che questo suo lungo, protratto, artisticamente sereno “silenzio” sia funzionale alla comprensione dell’opera stessa, legato a essa in quella circolarità spinoziana-deduttiva con cui tutto si tiene in Meneguzzo.
Allora e innanzitutto: questi due momenti in mostra a Castelgomberto rappresentano una svolta dai precedenti due fin dai nomi che li definiscono, che sono grammaticalmente differenti. “Sottrazione di colore” e “Verdi” non sono nomi collettivi di storici movimenti pittorici come lo erano “Astrattismo geometrico” e “Informale”; sono nomi propri e, in quanto tali, attribuibili soltanto all’opera di Franco Meneguzzo. Qui dunque già si palesa un cambio di livello tra i quattro momenti; si evidenzia un passaggio decisivo della sua pittura. Dal possedere uno stile secondo la lezione geometrizzante di Klee o elencabile tra i grandi dell’Informale italiano, Vedova, Tancredi, Scanavino… Santomaso… si è arrivati a inventare una propria, riconoscibilissima cifra stilistica, come accadde con i “tagli” di Fontana, con i “cretti” di Burri…; il passo è dalla parola alla lingua. Meneguzzo è giunto ad avere il suo idioma per il suo discorso artistico finale. Un idioma tecnicamente perfetto, tutto centrato sul processo di “sottrazione” che è la sintassi della sua pittura. Il colore è steso sulla tela, quindi, attraverso la tecnica dello strappo, che toglie colore dalla tela, e l’uso dell’acqua si realizzano quelle vibrazioni cromatiche, quegli effetti sfumati che danno origine al quadro. Non c’è più il pennello come strumento principe del dipingere. Come l’ultimo Tiziano usa le dita per imprimere il colore sulla tela, così l’ultimo Meneguzzo realizza tutte le sue opere applicando con le mani tela sulla tela, modulando all’uopo l’intensità dello strappo. Colore, acqua, tela assorbente e le sue mani, quelle mani divenute abilissime dal lungo esercizio di ceramista. Al centro della sintassi o della poetica della “sottrazione” c’è questa privazione dell’intermediazione del pennello.
Non c’è nulla, attenzione, d’intellettualistico in quest’operazione. Meneguzzo non fa, attraverso questa sua personalissima tecnica, l’ennesima novecentesca dichiarazione di morte, in questo caso della pittura, magari in senso classico, avendo egli eliminato, metaforicamente ucciso, il pennello, ma, tizianamente appunto, egli trova in questa pratica il modo per giungere all’opera perfetta, a quell’opera in sé compiuta, in cui si è realizzata la fusione tra l’artista e l’arte, tra le sue mani e la sua opera, tra il sé uomo e il sé poeta, secondo la definizione d’indeterminazione di Heisenberg, per cui “la posizione della particella e la sua quantità di moto sono in connessione tanto stretta che la particella e la sua onda sono insieme stesse e diverse”.
Causa ed effetto, ovvero, non sono più due momenti nettamente separati e percettibilmente distinti, ma, pur conservando la loro originaria distinzione, appaiono come una sola, inseparata cosa. L’artista-causa e l’opera-effetto del suo pensiero e del suo agire sono diversi ma anche i medesimi allo stesso tempo.
L’opera così è quel tutto in sé autonomo e compiuto che ha perso ogni traccia di artificio e volontarietà umana, da cui pur è originata.
Se nei “Penultimi” scompare il pennello, con gli “Ultimi” scompariranno i vivacissimi colori. E le tele saranno soltanto verdi. La tecnica è la stessa. La novità, però, negli uni come negli altri, non è solo tecnica-formale. Meneguzzo in forza del suo nuovo e più potente idioma tenta un discorso altro ed estremo nel codice dell’Astrattismo: spingersi oltre il concetto di quadro come puro segno, come pura immagine, come pura espressione formale; tentare qualcosa che appartenga all’eterno artistico al di là dell’ideologia astratta, senza tuttavia uscire dall’Astrattismo stesso: nei “Penultimi” il fine sarà la bellezza, negli “Ultimi” il discorso sarà etico-civile.
La bellezza, quindi, è al centro dei “Penultimi”, quella bellezza che la lunga stagione astratta aveva prepotentemente messo in secondo piano. Tacciata di vanità, di superficialità, di vacuo decoro. Meneguzzo aveva aderito con entusiasmo all’Astrattismo. Ne aveva colto da subito la potenza del messaggio metalinguistico. Se il quadro astratto in sé era puro segno, pura forma, significante quindi e non significato, fare l’astratto, invece, voleva dire esprimere, gridare addirittura la propria libertà di artisti e di cittadini di una nuova epoca, moderna e aperta; fare l’astratto significava partecipare a un radicale rinnovamento sociale, dopo la barbarie della guerra, dopo i totalitarismi della prima metà del Novecento e le loro oppressioni e atrocità. Fu, l’Astrattismo, una delle vie, e per Meneguzzo la principalissima, per scardinare quella società chiusa, bigotta, dogmatica, assolutistica, che fu quella del suo tempo. E lui, che aveva vissuto la guerra e l’aveva combattuta come partigiano, subendo il dramma dell’uccisione del padre trucidato dai nazisti, si ritrova in pieno nei valori dell’Astrattismo, che pratica fin dagli ultimi anni Quaranta e che lo porterà, nel 1953, a quella scelta di vita che fu il trasferimento da Valdagno a Milano, nella città dove più che altrove gli artisti astratti potevano trovare un favorevole contesto di critici e di gallerie disposti a dar loro appoggio e visibilità.
Meneguzzo entra quindi nel “sistema dell’arte” della Milano dei nuovi astrattisti. Frequenta artisti, Munari, Mari, e critici, Dorfles, Borgese, Vincitorio; mette su bottega con Bruno Danese; espone alla Galleria del Milione, alla Galleria Vismara, alla Galleria dell’Ariete, ma non diventerà mai del tutto un artista metropolitano. Il suo legame con Valdagno sarà sempre fortissimo ed è un legame che lo fa essere, nel senso alto del termine, un provinciale. Un incontaminato. Uno come Zanzotto, capace di chiedersi a margine del suo poetare così complesso e difficile: “cosa offriamo noi di realmente alternativo alla gente stanca dopo una giornata di lavoro, alle ragazze che stanno otto ore al giorno in una industria tessile nel frastuono dei telai o in altre situazioni faticose, stressanti? Si può capire molto bene il loro interesse per quei libri che le portano per un istante in una specie di favola rosea, al rosolio. Non possiamo pretendere che leggano libri troppo impegnativi”. Anche l’arte astratta è strabocchevole di pretese. Aspira a essere capita, sebbene, per statuto interno, ai quadri astratti non si possa dare alcun senso riferibile alla realtà condivisa, secondo cui un volto è un volto, un frutto, un frutto, una montagna, una montagna. In piazza a Valdagno, Meneguzzo viene avvicinato da persone che gli chiedono il senso dei suoi quadri; la ragione per cui avrebbero dovuto appendere sui muri del salotto o del salone di casa angoscianti scarabocchi neri, qua e là macchiati e bruciati, fossero pure di Burri.
La provincia è unica, meravigliosa e crudele nel pretendere le ragioni del proprio fare. A Milano, questo non accade, non perché la domanda non abbia senso, ma semplicemente perché gli artisti frequentano gli artisti o gli amici o gli operatori dell’arte, che in città sono tanti, e non la gente, come avviene in provincia, dove, di artisti, ce ne sono al più un paio, che, tra l’altro, quasi sempre campano d’altro.
E poi dalla metà degli anni ’50 sono sempre di più quelli che si mettono a fare quadri astratti. L’Astrattismo da pittura di pochi capaci artisti d’avanguardia diventa pratica artistica di massa. Ma se pittori della generazione di Meneguzzo erano arrivati all’Astrattismo attraverso un percorso intellettuale e artistico che aveva la sua origine nella tradizione figurativa, che garantiva a loro, e a noi, un riconoscibile sapere tecnico, adesso vi erano i “nativi astratti”: eserciti d’imbrattatori di tele che avevano miseramente creduto di trovare nell’assenza della figura e nella libera esplorazione dell’inconscio il modo per nascondere e giustificare la loro insipienza segnica.
Non solo. Anche la critica d’arte, aspirando a essere formale-strutturalista come la critica letteraria, senza oggettivamente avere una lingua, che sottintende una grammatica, una metrica, una stilistica, una retorica e anche una storia della lingua stessa, ovvero un’ampia rosa o un’intricata selva di elementi strutturali-formali su cui lavorare, si era fatta genericamente e vacuamente “astratta”. Pagine e pagine su teorie di linee che diventano angoli e poi curve e infine cerchi; macchie di colori tonali che diventano timbriche strisce striate, in cui il senso del tutto è quello di essere meravigliosamente se stessi tra i simili e i dissimili della grande storia dell’arte contemporanea.
Meneguzzo ne parla, ne soffre: lo offende il basso livello, letteralmente l’involgarimento, in cui sta precipitando l’arte astratta; lo turba il ragionare sempre più avvitato su se stesso e sempre più finalizzato all’affarismo della critica d’arte. In quello che vede, in ciò che legge non riesce più a percepire la presenza della dantesca “pantera profumata”, metafora della lingua perfetta, ma anche della bellezza, dell’intelligenza, della poesia, che, quando ci sono, lasciano il loro odore dovunque, senza lasciarsi vedere in nessun luogo. E da provinciale, ovvero da isolato che si confronta con la realtà altra, quella non intellettualistica e autistica dei circoli cittadini, intraprende la sfida di produrre bellezza in quel canone che, per principio, l’aveva considerata un disvalore. Bellezza in senso classico, fatta di misura, armonia, simmetria, composizione, accordi cromatici, all’interno di quell’Astrattismo che aveva esaltato l’esatto contrario: lo spontaneismo del gesto, il segno che originava dall’inconscio, l’accidente casuale, l’automatismo robotico, la materia abrupta.
Così per il suo fine, la bellezza astratta, Meneguzzo recupera le sue precedenti esperienze: lo spazialismo del geometrismo astratto e le combinazioni cromatiche sperimentate nel suo periodo informale. E il risultato sono i “Penultimi”, sapienza di composizione e sapienza di colore. Estro ed esattezza. Precisione e ispirazione.
Poi, con gli “Ultimi” il discorso da estetico si fa civile. Rimangono il rigore geometrico, i moduli vibrati, ma le combinazioni cromatiche sono, adesso, nella scala del verde. Il primo quadro del periodo “Verde” è del 1963 e ha per titolo “Il verde è necessario”. Meneguzzo fu il primo in arte, come lo fu Zanzotto in letteratura, a comprendere che il grande tema della contemporaneità sarebbe stato la vita dell’uomo nell’età della tecnica tra la necessità del progresso industriale e la necessità della conservazione naturale.
Alla mostra dei “Nani” del ’73, attorno a cui si snoda il nostro ragionamento, i quadri esposti sono quelli del periodo “Verde” e il messaggio ai suoi “concittadini”, che all’ombra della Marzotto vedevano crescere i capannoni di quello che sarebbe diventato il Nordest delle piccole, medie imprese, è questo: progresso e ambiente, mediante l’unica persuasione possibile, quella dell’arte. Educarsi al verde attraverso il discorso più alto, quello culturale, unica via, per Meneguzzo, all’autentico miglioramento di sé nell’aumento di coscienza del mondo.
Quel pomeriggio del dicembre ’73 ai “Nani”, tra gli invitati, c’era anche lo scrittore Antonio Pizzuto. C’è una lettera all’editore Alberto Mondadori in cui Pizzuto anticipa il suo prossimo arrivo a Valdagno in occasione della mostra e una foto pubblicata su “La taverna di Auerbach” del 1988 che li ritrae assieme nella casa valdagnese del pittore. Pizzuto era nato a Palermo nel 1893, era stato vicepresidente della Commissione Internazionale di Polizia Criminale, quella che si sarebbe poi chiamata Interpol, quindi fu vicequestore a Trento e questore a Bolzano, ed era uno dei più colti e complessi scrittori italiani del tempo. Aveva 80 anni, quando arrivò a Valdagno per la mostra di Meneguzzo. Si erano conosciuti in Svizzera nella casa di Madeleine Santschi, collezionista di Meneguzzo e traduttrice per Gallimard dell’opera di Pizzuto. In “Pagelle II” Pizzuto evoca i quadri di Meneguzzo appesi alle pareti di casa Santschi come “ardui meneguzzi turchesi, nilo, erba”. Pizzuto fu una figura importante per Meneguzzo. Dopo l’incontro a casa della Santschi, che risale alla fine degli anni Sessanta, tra i due nascerà una filiale amicizia, che non verrà mai meno fino alla morte dello scrittore, avvenuta nel 1976. Meneguzzo, che aveva perso il padre, ucciso dai tedeschi in ritirata, alla fine dell’aprile del 1945, avvenimento, questo, per lui giovanissimo partigiano, fortemente traumatico, trova in Pizzuto, che aveva quasi il doppio della sua età, la figura paterna mancante, a cui guardare con ammirazione, ma anche con cui confrontarsi nelle reciproche scelte artistiche.
La presenza di Pizzuto ai “Nani” dà un particolare rilievo all’evento. Pizzuto è il massimo scrittore sperimentale italiano. Nessuno più di lui si è spinto ai limiti delle possibilità espressive della prosa. Di lui Gianfranco Contini ha scritto: “traumaticamente perfetto, rotondo, catafratto in una maturità che è un magistero”. Sorprendentemente anche per la prosa di Pizzuto è possibile parlare di una “sintassi della sottrazione”. Di libro in libro egli elimina l’uso della prima persona, ricorrendo solo alla terza persona, che è detta anche la non-persona, poi abolisce la coniugazione del verbo, che utilizza solo all’infinito o al gerundio o nei declinabili participi, già più nomi che verbi, fino ad arrivare a “sottrarre” dalla frase il verbo stesso per una sintassi tutta nominale.
Togliere il verbo in prosa significa privarsi dell’azione, del racconto di un divenire. Equivale, in pittura, all’eliminazione del pennello come strumento dell’azione di dipingere. L’esito delle pagine di Pizzuto è del tutto simile a quella indeterminazione di causa-effetto degli “Ultimi” e “Penultimi” quadri di Meneguzzo. Come nei quadri l’immagine non è più dipinta, ma è in se stessa, nelle pagine di Pizzuto il racconto non è più narrato, ma accade.
Curiosamente tutto questo si è maturato nei due artisti almeno dieci anni prima del loro incontro. E ancor più curiosamente non vi è alcuna traccia di un reciproco riconoscersi nella disciplina dell’altro. Alla poetica della sottrazione giungono autonomamente “non per un programma”, sono parole di Pizzuto, “precostituito, che significherebbe scuola, ma per combinato concorso di spontaneità e logica” e, potremmo aggiungere, per una profonda adesione all’autentico spirito artistico del tempo, quello che arriva ovunque, anche nel chiuso degli studi o nei cieli di provincia, e che non va confuso con le istanze di corrente dei vari maître à penser; quel senso del presente che ha portato le menti più geniali a fare arte usando la cultura, sentita non solo come patrimonio di conoscenza teorica, ma come materiale corporale di produzione, sperimentazione e innovazione artistica. Tutta la poesia del Novecento, Pound, Eliot, Montale, Zanzotto, è poesia della cultura; tutta la prosa del ‘900, Joyce, Mann, Musil, fino a Borges, a Gadda, a Pizzuto, a Bellow, ad Arbasino è prosa della cultura. E così sarà anche la musica dodecafonica, il cinema da Bergman a Fellini, e l’arte astratta, per la quale, come per tutte le altre espressioni artistiche, i riferimenti e i legami culturali costituiscono il primo, imprescindibile, elemento di legittimità vivens. Coerentemente con lo spirito del tempo, i titoli scelti da Meneguzzo per i suoi quadri hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, raffinatissimi richiami alla cultura, quale concausa d’ispirazione e quale traccia orientativa per una loro possibile interpretazione.
In quel dicembre del ’73 ci sono, ai “Nani”, due giganti dell’arte e della letteratura del XX secolo. Nessuno si è spinto come Pizzuto al limite della prosa; nessuno come Meneguzzo ha portato l’Astrattismo alle sue massime conseguenze.
Tre anni dopo quella mostra, Pizzuto verrà a mancare e postumo, per l’editore “il Saggiatore”, uscirà un suo libro intitolato “Ultime e Penultime”. Vi sono contenute, da cui il titolo, le prose penultime e ultime di Pizzuto. Oggi, tuttavia, dalla prospettiva storica che ci è permessa, comprendiamo che con quel titolo Pizzuto ha stabilito con esatta precisione il punto di termine della scrittura sperimentale della letteratura italiana del Novecento. Dopo di lui nessuno, di fatto, ha tentato, e ha potuto, una scrittura altrettanto estrema.
Ma prima di Pizzuto e soprattutto indipendentemente dalla contingenza forzata del trapasso, Meneguzzo arriva con totale volontarietà e piena consapevolezza a questa identica conclusione. Sappiamo che la mostra ai “Nani” è stata l’ultima di Meneguzzo artista militante. Le successive lo avrebbero visto solo e sempre nei panni di un artista in off. Espone, ma non dipinge. Oggi possiamo capire che non l’ha più potuto e voluto fare per ragioni di coerenza artistica. Dopo le tele della “Sottrazione di colore”, in cui aveva inseguito la bellezza astratta, e dopo i “Verdi”, in cui era riuscito, attraverso il ripetuto, insistito e rituale uso del colore verde, a comunicare il suo messaggio etico civile, Meneguzzo aveva compreso di essersi spinto ai limiti del codice astratto, oltre i quali non sarebbe più potuto andare senza tradirne il genere e infrangere il matematico rigore di tutta la sua storia artistica. Solo un protratto silenzio, una vedovile astinenza dall’arte praticata nell’assoluta fedeltà al codice astratto, avrebbe potuto essere, per quanto crudelmente precoce, il logico, coerente atto finale dell’opera di una vita. Per questo, in questa lucida visione dell’arte del suo tempo e dell’arte da lui prodotta, smette di dipingere. Così, quel lungo, consapevole, volontario “silenzio”, che ha avuto inizio nella sua Valdagno al cospetto dell’amico-padre-maestro e che è durato inflessibilmente per 35 anni, ci fa pensare e ci fa dire che i quadri della “Sottrazione di colore” e i “Verdi” siano, in assoluto, i penultimi e gli ultimi di quella straordinaria stagione che fu l’Astrattismo italiano.
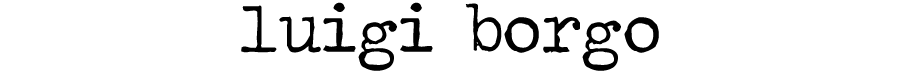




Leave a Reply